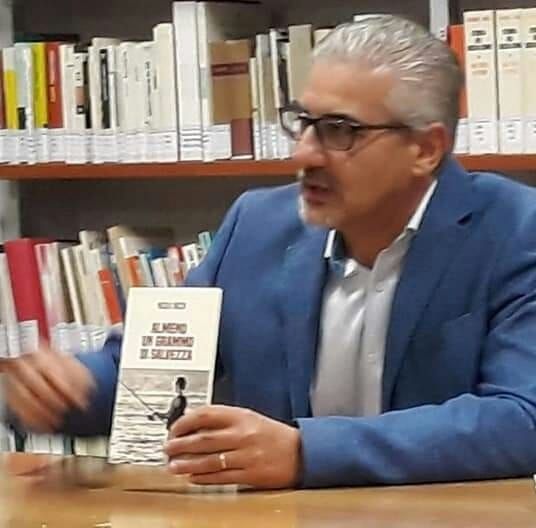Del pallido delinquente
I giudici sono i ministri del sacrificio dell’uomo che è perfettamente consapevole della sua colpa, quell’uomo è diventato pallido al cospetto della sua colpa e del risultato della sua azione, egli provato dal suo crimine desidera la propria morte: dalla passione violenta, dal desiderio di sangue si arriva al crimine, preparando così la propria morte, ma tutto questo è la conseguenza di un cumulo di malattie sociali. Il pallido delinquente è un malato sociale.
L'istinto ad uccidere, il desiderio di sangue, scaturiscono dall'inconscio del pallido delinquente ed hanno origine dal suo Sé. La malattia sociale è la conseguenza del male del nostro tempo, il male che egli fa agli altri è il male sociale che fa del male a lui. Esistono molte definizioni del bene e del male, così, quello che oggi è considerato bene o è considerato male, una volta non lo era affatto.
Il male del nostro tempo, pregno di relativismo e nichilismo, non consente di discernere quale sia il vero male, pertanto senza conoscenza non è possibile liberamente deliberare, ricadendo nella malattia del Sé, senza poter quindi riconoscere la propria colpa: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).
Socrate ci ha tramandato un concetto fondamentale: conoscere il male permette di evitarlo. Non essere a conoscenza di ciò che può essere male significa che l’uomo può non consideralo tale, di conseguenza vale a metterlo in pratica come se fosse bene. Per Socrate “nessuno fa il male volontariamente”, diventa fondamentale la questione della subordinazione della volontà alla conoscenza, dalla quale paradossalmente ha origine l’involontarietà del male. Emerge così una potente dinamica: il cosiddetto intellettualismo etico di Socrate, il bene, una volta conosciuto, attrae incontenibilmente la volontà dell’uomo. “Se il piacere è bene, nessuno, sapendo o credendo che altre possibili azioni siano migliori di quelle che compie, fa le peggiori, mentre potrebbe compiere quelle migliori […] è contrario all’umana natura ricercare ciò che si ritiene male invece del bene” questa una delle celebri affermazioni di Socrate, riportata dal suo discepolo più illustre, Platone, nel Protagora.
Se dunque le epidemie, le guerre, le crisi economiche, i tagli allo stato sociale, l’impoverimento generalizzato e la negazione dei diritti, sono malattie sociali che si cumulano sedimentandosi nell’uomo come una malattia individuale, stendendo un velo sullo sguardo rivolto al male, tanto da non riconoscerlo, allora perché nel nostro tempo così razionale assistiamo ad un'espansione della pena, conseguenza di un male inconsapevole?
Il carcere è l’apparato di sorveglianza e punizione, di vera e propria vendetta sociale che, come scriveva nel 1899 Lev Tolstoj: “queste istituzioni portano la gente al massimo di vizio e corruzione, cioè aumentano il pericolo”, inoltre il sistema non è riformabile, visto che “delle prigioni perfezionate costerebbero più di quanto si spende per l’istruzione pubblica e graverebbero ulteriormente, ancora una volta, sul popolo” (Resurrezione, Garzanti 2002).
Così anche Filippo Turati in un discorso alla camera dei deputati: “Le carceri italiane rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta: noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori”.
Oggi, più che mai, è necessaria l’applicazione dell’art. 27 della nostra Costituzione, ove si afferma che: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” riducendo i limiti massimi di pena per i reati non di sangue, smantellando la struttura carceraria e trasferendo le risorse al sistema dell’affidamento ai servizi sociali. Anche perché gli assassini, i mafiosi e i trafficanti internazionali di droga sono “a malapena il 10 per cento del totale” e “i reclusi sono destinati in una percentuale elevatissima, più del 68 per cento, a commettere nuovi delitti”. La percentuale scende al 19 per cento tra chi è affidato in prova ai servizi sociali, si legge in uno studio del 2007 curato dall’osservatorio delle misure alternative (Abolire il carcere, Chiarelettere 2015).
Se la pena è un costo da pagare allora deve essere proporzionata al tempo che è necessario impiegare per capire ed espiare, per trasformare la colpa in responsabilità: il carcere deve essere un luogo per lavorare, per studiare, per riflettere su se stessi, sui propri legami di vita e sulle proprie decisioni. Il carcere deve poter essere un luogo per comprendere la libertà.